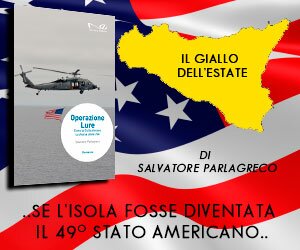Il positivo di questo periodo in cui tra chi legge e chi scrive si parla molto di fact-checking e di fake news è che sembra diventato normale (finalmente) porsi delle domande che prima sembravano appartenere a un altro pianeta, sul giornalismo italiano. Uno degli esempi che sarebbe da seguire è quello del New Yorker Journal, il quale ha all’interno della sua redazione un processo di fact-checking davvero unico, quasi leggendario: si avvale di una squadra di venti professionisti di prim’ordine, tanto di budget, prassi e conoscenza sedimentati nel tempo, e, di più, la volontà di mettere in dubbio quello che scrivono i giornalisti, e la disponibilità, da parte di questi ultimi, all’idea che il loro lavoro venga quindi controllato. Certo il fact-checking ha tutta l’aria di essere un vero e proprio processo dove il giornalista è l’imputato e il fact-checker è l’avvocato del diavolo: prende un articolo, lo fa a pezzi e poi prova a rimettere i pezzi insieme, procedura che rischia senz’altro di offendere qualcuno perché quanti sarebbero veramente disposti a rendersi più vulnerabili per essere più credibili?
La vera domanda è se questo lavoro ha un reale impatto, cioè se esistono dati concreti, fatti, che dimostrino che mettere a nudo menzogne e inesattezze aiuti ad arginarle, soprattutto alla luce di un “fatto simbolo” sotto gli occhi di tutti: Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti nonostante le sue dichiarazioni sono state valutate sette volte su dieci “false”, “completamente campate in aria” o “prevalentemente false” da siti attendibili tra cui “PolitiFact”.
C’è chi dà la colpa a Internet, alle bufale che rimbalzano sui social più delle notizie vere. Altri hanno fatto notare, già in tempi pre-Social, che si tratta di un divorzio -quello tra politica e verità- inevitabile, non tanto per la vulgata populista secondo cui “i politici sono tutti bugiardi”, ma per la natura intrinseca del dibattito politico: se conta l’opinione della maggioranza, allora è consequenziale che la percezione dei fatti abbia un impatto maggiore dei fatti stessi. A meno che non si voglia pensare che esista una “mano invisibile” che porti all’auto-regolamentazione del “mercato delle idee”, nulla fa pensare che, dove c’è dibattito, debba prevalere per forza l’idea corretta: al contrario, per citare Hannah Arendt, la verità “preclude il dibattito”.
Che senso ha fare fact-checking in un’era di disinformazione di massa, dove “la debolezza dei fatti è il cuore del problema”?, domandava in una recensione il Washington Post. Il fact-checking è sacrosanto ma è ininfluente, conclude.
Recentemente l’Oxford Dictionaries ha dichiarato parola dell’anno “post-truth” (post-verità) un “aggettivo che denota circostanze in cui i fatti obiettivi sono meno influenti nel formare l’opinione pubblica rispetto alle emozioni e alle convinzioni personali”. Per molti nerd del web il concetto è iniziato a circolare già una decina di anni fa, quando alcuni commentatori tecno-scettici hanno cominciato a riflettere sul fatto che la diffusione di Internet potesse indebolire il nostro rapporto con la realtà, qualcosa che avrebbe contagiato anche (soprattutto) la scrittura. Internet ha creato un mondo post-verità. Però, se è vero che la rete ha esacerbato la tendenza umana a vedere ciò che si vuole vedere, è anche vero che ha amplificato un altro comportamento, altrettanto umano e pre-Internet: esprimere opinioni e discuterne. Paradossalmente, anche questo aiuta a capire l’evaporazione dei fatti.
Nel 1967 Hannah Arendt ha pubblicato sul New Yorker il saggio intitolato Verità e politica (in Italia pubblicato da Bollati Boringhieri) che vale la pena ricordare; questo saggio ha anticipato per alcuni versi il dibattito odierno sulla post-verità: «Mentre probabilmente nessun’altra epoca storica ha tollerato tante opinioni diverse, mai come oggi la verità fattuale è stata recepita con tanta ostilità», scriveva. Il problema è che “il pensiero politico è rappresentativo”, si basa cioè sul “concordare dei molti”, dunque sul dibattito e sulla capacità di convincimento. Mentre la verità è l’esatto opposto, è “di natura dispotica”: un fatto è o non è, non c’è nulla da dibattere. Anche nel “concordare dei molti”, può capitare che la verità s’imponga; ma avviene raramente, perché “chi mente è spesso più convincente”. Anche quando la verità prevale, proseguiva, è “una vittoria di Pirro”, perché significa che s’è imposta in quanto opinione più convincente, non in quanto verità “al di là del dibattito”.
Se la politica è rappresentativa e dunque dibattito e dunque opinioni, allora bisogna ammettere “la natura anti-politica” della verità. Osservazione estremamente attuale perché solleva questioni non solo sul clima di post-verità, ma anche sui populismi che da esso traggono forza. Quasi un eccesso di libertà di espressione e di rappresentatività, dove cento cittadini che dicono che i vaccini causano l’autismo contano più di dieci scienziati che dicono che non è vero.
Ma chi decide cosa è vero? E che valore ha decidere cosa è vero ora che i fatti contano sempre meno? Nonostante la loro ininfluenza, sono i fact-checker , di fatto, a decidere che cosa è vero.
In Italia siamo abituati a un’idea un po’ strana del fact-checking: è qualcosa che si fa quando un articolo è già uscito; lo si fa, in genere, su Twitter, su un blog, più raramente su un altro giornale. Difficilmente un articolo è sottoposto a fact-checking prima di essere pubblicato, all’interno della stessa redazione come accade negli Stati Uniti. Sarà anche per questo, forse, che spesso il giornalismo statunitense è ritenuto, e non del tutto a torto, più affidabile di quello nostrano. E non si tratta di un processo economico indolore: fact-checking significa richiamare una ad una tutte le fonti che sono citate in un articolo, con un certo dispendio di tempo e di denaro; l’uscita di un pezzo viene rallentata, in più c’è gente pagata solo per fare quello. Per un giornalista inoltre non dev’essere un’esperienza piacevole visto che si tratta di mettere in dubbio stima e fiducia personali.
Mario Morcellini nel suo libro “Neogiornalismo, Tra crisi e Rete, come cambia il sistema dell’informazione” – ha spiegato così il fenomeno: “la crisi della mediazione giornalistica è il portato del processo di svuotamento delle relazioni significative con istituzioni, politica e vita pubblica che in qualche modo facevano da interfaccia ai bisogni dei soggetti di costituirsi come personalità e identità. Il disincanto del mondo è corrisposto al disincanto del giornalismo in quanto racconto del mondo”.
Nietzsche sosteneva che la verità non esiste ed è solo uno strumento del potere. Il vero paradosso di questi ultimi decenni è tuttavia che la proliferazione delle fake news nell’era della “post verità” sta avvenendo attraverso un sistema, quello del web, che si proponeva come espressione della democrazia partecipativa e che invece si è dimostrato essere un mezzo antidemocratico per eccellenza perché fa leva sul deficit di strumenti di lettura della realtà da parte di molti. Un tempo si diceva: “l’ha detto l’Ansa, quindi è vero”; oggi è indifferente se l’abbia detto o meno l’Ansa: le sanzioni per chi pubblica notizie false sono servite a ben poco nei confronti dei media tradizionali, figuriamoci quale effetto deterrente potrebbero avere per la rete. Diventa quindi importante non che si sappia discriminare tra verità e falsità ma che il modo di riconoscere le autorità sia sano: in un mondo ad alta densità di informazione paradossalmente la nostra dipendenza dagli altri per filtrare il sapere è ancora più profonda. Bisogna imparare a capire quali sono i segnali legittimi per dare autorità a qualcuno e quali quelli illegittimi.
Intanto qualche strada si è aperta; si può per esempio accedere a siti come Piazza Bocca della verità, ovvero “Biblioverifica”, che riporta news da fonti ufficiali e verifica news a partire dalle richieste online di bibliotecari e archivisti volontari che aderiscono e collaborano al Manifesto IFLA contro le fake news, e che ha l’obiettivo di agevolare l’accesso all’informazione responsabile: condividendo strategie, strumenti e metodi basati sui principi di accuratezza, tracciabilità, indipendenza, legalità, imparzialità- dove si può approfondire, verificare l’autore, trovare le fonti a supporto, verificare la data, sapere se è uno scherzo, verificare i propri preconcetti, chiedere agli esperti. Attraverso questo sito è possibile utilizzare Open Data, fonti istituzionali verificabili in modo autonomo, libero e gratuito. In sintesi è un sito che si ripropone di divulgare strategie, fonti e strumenti utili al cittadino per praticare autonomamente il fact checking che consente di avere una risposta ai dubbi attivando un processo di collaborazione civica in Rete. Educare al tempo dei social non è un passatempo o un divertimento, ma è diventata una priorità della società moderna: i pericoli legati alle fake news non saranno risolti con i divieti, ma con una sana e buona educazione all’utilizzo del mezzo.
Bisognerebbe ricordare però che esiste “fisicamente e geograficamente” una istituzione che potrebbe svolgere questo compito anche meglio che virtualmente: la Biblioteca pubblica di Base del III millennio. La biblioteca è già il luogo deputato a svolgere attività utili agli utenti/cittadini per comprendere, ricercare, selezionare e valutare le informazioni derivate dagli Open data della Pubblica Amministrazione; in poche parole a offrire, in qualità di servizio, un insieme di abilità per saper riconoscere l’informazione e per essere capaci di localizzare, valutare e utilizzare efficacemente l’informazione necessaria. Che significa inoltre aiutare ed educare gli utenti/cittadini a recuperare notizie attendibili relative ai dati della Pubblica Amministrazione grazie anche al data journalism, utile a sua volta per la trasparenza e il monitoraggio sull’attività della stessa Pubblica Amministrazione. In fondo bibliotecari e giornalisti non sono altro che dei mediatori culturali cui spetta il compito di preparare i lettori a utilizzare in modo corretto l’informazione disponibile su Internet: nel nuovo contesto è più che mai necessario educare all’information literacy, ovvero alla competenza nella gestione corretta delle informazioni come d’altronde suggerisce da tempo l’Aib (Associazione Italiana Biblioteche). Paolo Traniello – il più attento studioso italiano di questo tema specifico – ha affermato che “a partire dalle fasi storiche successive alle due guerre mondiali, l’idea di biblioteca pubblica è stata fortemente caricata di valori che andavano oltre le funzioni strettamente e specificamente bibliotecarie (…) per assumere intense connotazioni politiche e sociali. In sintesi, la biblioteca pubblica è stata vista come una delle più importanti realizzazioni della moderna democrazia rappresentativa, fondata su principi di uguaglianza nell’offerta di opportunità di crescita culturale e di libertà di accesso all’informazione. È evidente come questa acquisizione sia il risultato di una progressiva declinazione dell’idea di biblioteca pubblica proposto a livello internazionale dal documento che segna un discrimine sostanziale nella riflessione bibliotecaria, ovvero il Manifesto dell’Unesco per le biblioteche pubbliche del 1994. Il Manifesto esordisce con questa dichiarazione programmatica: “La libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui sono valori umani fondamentali. Essi potranno essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i loro diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società. La partecipazione costruttiva e lo sviluppo della democrazia dipendono da un’istruzione soddisfacente, così come da un accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all’informazione. La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per l’apprendimento permanente, per l’indipendenza nelle decisioni, per lo sviluppo culturale dell’individuo e dei gruppi sociali”.
A queste dichiarazioni di intenti internazionali si è aggiunto ancor più di recente il cosiddetto “Manifesto di Alessandria” intitolato “La società dell’informazione in movimento”, approvato ad Alessandria d’Egitto nella ricostituita Biblioteca Alessandrina nel Novembre 2005. Qui l’accento è posto sulla biblioteca in rapporto con le nuove tecnologie ma anche sul valore etico ed economico della sua azione nell’era dell’informazione onnivora. Il “Manifesto di Alessandria” afferma che “Le biblioteche e i servizi per l’informazione contribuiscono alla piena realizzazione della società dell’informazione globalizzata. Essi rendono possibile la libertà intellettuale, fornendo accesso a informazioni, a idee e a opere dell’immaginazione espresse con ogni mezzo e al di là di ogni frontiera. Essi aiutano a salvaguardare i valori democratici e i diritti civili universali in modo imparziale e opponendosi a ogni forma di censura. Le biblioteche sono fondamentali per l’esistenza di una cittadinanza bene informata e di un governo trasparente, così come per l’incentivazione dell’e-government. Esse, inoltre, generano capacità promuovendo l’alfabetizzazione all’uso delle informazioni e fornendo supporto e istruzioni per un impiego efficace delle risorse informative, incluse le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.
La ragion d’essere della biblioteca pubblica contemporanea deve – e dovrà sempre di più – ridefinire la propria identità e agire da protagonista sul terreno conteso dagli straripanti social media e social network, fornendo contesti fisici e strumenti di partecipazione.
La rete Internet in cui tutti siamo immersi è un immenso bacino cui attingere ma proprio la sua dimensione rappresenta anche il suo limite: una cosa è trovare miriadi di informazioni, un’altra è distinguere quelle affidabili e, soprattutto, selezionare le più rilevanti. Mai come ora è necessaria una nuova competenza critica in grado di ridurre il rumore di fondo dell’universo informativo che sappia individuare cosa è credibile e che ci fornisca le abilità per riconoscerlo. Sottrarsi al flusso pervasivo della comunicazione inoltre è indispensabile per salvaguardare le funzioni fondamentali della persona che ha la necessità di ricomporre le tessere dell’informazione segmentata, di metabolizzare ciò che apprende, di riflettere, di rielaborare i concetti, di costruire se stessa nello spazio e nel tempo, mettendo fine alla separazione tra cultura umanistica e cultura tecnica per affrontare le sfide della globalità e della complessità. La sfida è in definitiva che la biblioteca stessa recuperi e consolidi lo spirito social che è da sempre nel suo DNA a condizione però che esca dalle “mura” in cui a lungo si è rinchiusa, approfondendo la conoscenza del profilo della comunità di riferimento, aumentandone l’ascolto, intercettandone i bisogni, attivandone le energie, favorendone le relazioni, verificando in itinere la sintonia con l’ambiente che l’ha generata e l’alimenta, con il quale deve mantenere e rafforzare i legami di reciprocità dando impulso e affinando le strategie di inclusione anche attraverso l’uso della tecnologia.