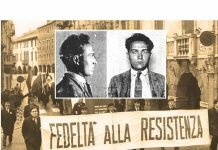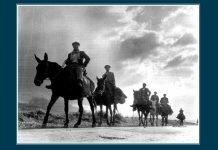Il poeta palermitano Emilio Paolo Taormina è più noto all’estero che in Italia. Lo è soprattutto in Germania e in Spagna, dove di recente è stata pubblicata una sua silloge inedita, ed è stato tradotto in tante lingue, comprese l’albanese, l’armeno, il montenegrino. Come può accadere un simile fenomeno: riscuotere più successo fuori dall’Italia che nel nostro Paese? Per spiegarlo, occorre una riflessione sulla diffusione della poesia in Italia. Man mano che passano gli anni, nella penisola la poesia gode sempre più di minor credito. Naturalmente ciò è dovuto, innanzitutto, all’impoverimento culturale che attraversa l’Italia, dall’estremo nord all’estremo sud, per ragioni su cui non ci si può soffermare e che comunque chiamano in causa in primo luogo la scuola e i media. Ma tanto da solo non spiega l’idiosincrasia per la poesia: c’è dell’altro. La crisi economica che ci ha afflitto in questi anni ha inferto gravi fendenti all’industria editoriale. Che ha risposto concentrando la sua produzione sui generi che garantiscono investimenti più sicuri. E certamente la poesia non rientra tra questi. La poesia non ha mercato e non finisce sugli scaffali delle librerie, se non in piccoli e nascosti angoli. In questo modo la “notorietà” dei poeti (tra virgolette, ché tale non può definirsi) non è determinata dai lettori –a cui la poesia non è offerta -, ma da elitari e spesso autoreferenziali circoli letterari. Emilio Paolo Taormina non appartiene, né mai è appartenuto, ad alcun circolo letterario: ha sempre vissuto rinchiuso tra le sbarre di una prigione dorata, quelle del suo singolare e luminoso universo poetico; anche quando, per tanti decenni, è stato titolare di uno degli esercizi commerciali più prestigiosi di Palermo, “La boutique della musica” (la famiglia Taormina ha avuto un’importanza non trascurabile nella diffusione della musica classica, lirica e jazz a Palermo e in Sicilia), e ora che abita in mezzo agli ulivi. Rapito com’è dal demone della poesia, Taormina non ha tempo, né mai ne ha avuto, per frequentare conventicole o salotti d’ogni tipo. Di recente, la Linea dell’Equatore ha stampato in cento copie una sua elegante plaquette artigianale dal titolo “Gelsi neri”. Una silloge, “Gelsi neri”, che dà seguito al discorso poetico di Taormina, già iniziato negli anni ’50, quand’era ragazzo, e mai interrotto. Si tratta di una poetica, quella di Taormina, costante e uniforme nel tempo, verrebbe da dire monocorde se questo aggettivo non tendesse ad assumere, nell’uso più consueto, una connotazione limitativa. La vena lirica dell’autore palermitano trova ispirazione, oltre che in un’interiorità sensitiva ( e cioè in un’accentuata, quasi morbosa capacità di sentire che solo i poeti possiedono ), nella contemplazione della natura – ora rapita, ora partecipe dei suoi processi, ora fonte di riflessioni o di abbandoni malinconici.
Leggendo “Gelsi neri”, la parola “luna” si ripete numerose volte. Qualcuno potrebbe pensare che ciò sia spia di trascuratezza, eccesso di semplicità e scarsa inclinazione all’elaborazione che accompagna la creatività lirica. Ma sbaglierebbe di grosso. Intanto, la luna è presente nella poesia da sempre, in modo quasi ossessivo, al punto che Calvino ha confessato, nelle “Lezioni americane”, che avrebbe voluto dedicare la prima delle sue conferenze all’Università di Harvard ( quella poi incentrata sulla leggerezza) sulle “apparizioni della luna nelle letterature d’ogni tempo e paese”. Inoltre, è la luce della luna che prevalentemente illumina il paesaggio campestre dell’universo poetico di Taormina, dando quel tocco di soffusa mestizia al suo canto, tanto che molti dei suoi brevi componimenti riecheggiano le “ sonorità flebili” (titolo di una poesia di Fo nella raccolta “Mancanze”) dei notturni di Chopin: “Mille sfumature in movimento, / infiniti impensabili dettagli / al livello estremo di dolcezza / protetto nel superlativo del piano” (Fo). Non vi è eccesso di semplicità nelle liriche di Taormina, ma semplicità; quella semplicità che è un dono della poesia pura, che scorre inesauribile con la limpidezza dell’acqua di un ruscello. E però i suoi versi, sebbene Valentina Meloni nell’intelligente postfazione osservi come la “revisione dei testi” non sia mai “eccessiva per ammissione stessa dell’autore”, sono frutto, nella ricerca dell’essenzialità, di fatica letteraria. Lo testimonia il poeta in una delle sue liriche: “dà i brividi / dopo avere / contorto / le parole / per giorni / vederle scorrere / in un verso / come acqua / e leggere / nel loro fondo”. Taormina è il poeta della natura. Le sue metafore e le sue similitudini, mai forzatamente ricercate, attingono dalla natura. I suoi sentimenti s’incarnano nei moti e nelle creature della natura, siano essi sentimenti di tenerezza ( “vorrei tenerti / tra le braccia / come l’agnello / smarrito / per la collina / che il pastore / porta alla madre “ ), d’amore ( “sei nuda / come un’onda / che si struscia / tra i sassi” ), di tristezza ( “al largo / l’estate va via / porta sui carri / aromi di more / di fichi / come un animale / che muore / ha negli occhi / un velo di luce”), di nostalgico rimpianto di un passato che non ritorna, come nei toccanti versi della poesia dedicata all’albero dei gelsi neri da cui il titolo alla raccolta. La natura è così avvolgente nella poesia di Taormina dal rivelarsi anche nelle calamità e nel degrado, dal mitigare la paura della morte, dal proiettarsi in dimensioni oniriche metafisiche (“gradino / dopo gradino / saprai / che ce l’hai fatta / quando / potrai fumarti / una sigaretta / accanto alla luna”).
La critica ha accostato la poesia di Taormina alla tradizione giapponese degli haiku per la brevità dei componimenti e i richiami naturalistici, oppure alla stagione del Novecento italiano della “poesia pura” per la scarnificazione sino all’essenziale del suo dettato, o ancora al “frammentarismo” per il mosaico di immagini della sua trama. Tali riferimenti, per quanto appropriati, non colgono da soli l’essenza della poesia di Taormina, che ha una singolarità che la rende refrattaria a ogni tentativo di “catalogazione”. Si può solo dire che, quella di Taormina. è una poesia intrisa di liricità, che giunge ai lettori direttamente, senza mediazioni cerebrali, antica nei temi e moderna nel linguaggio, classica, perché in essa prevale misura, equilibrio, armonia: la misura, l’equilibrio, l’armonia della natura.