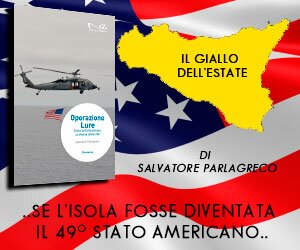Come già segnalato, ho curato di recente tre volumi su questi argomenti. Sono stato stimolato a spiegarli e ad introdurre meglio il tema. Qui lo faccio.
- I due mondi psichici mafia e fondamentalismo nei nostri studi si incontrano a partire dal fatto che la mafia, con i fondamentalismi, ha una base etnico-familiare monolitica (ci riferiamo a Cosa nostra, ‘Ndrangheta, Casalesi, Triadi Cinesi. Non a Camorra, mafia nord-americana, mafia capitale, mafia Colombiana che sono organizzazioni criminali più legate a delinquenza e situazione socio-economica). Le mafie “d.o.c.” ( e cioè a base identitaria e di totale appartenenza) fanno coincidere l’identità individuale con quella familiare (in senso ampio) ed antropologica. Il mafioso non ha, inconsciamente, la dimensione dell’io individuale (tranne, forse, in qualche aspetto biologico). Esso coincide con il noi mafioso. Questo determina indifferenza ad ogni forma di alterità (l’altro è nemico o non persona ed in questo somiglia a nazismi, stalinismi, populismi, terrorismi, ecc.), scarso interesse per relazioni affettive e sessuali. Unica vera motivazione profonda: il potere in cui l’onnipotenza individuale (devi avere terrore di me, ecc.) coincide con quello dell’organizzazione/famiglia. In Cosa nostra, ad esempio, non ci sono lussi, belle donne, ecc., come nei film americani. Un mafioso è psichicamente peggio di un terrorista jihadista, di un razzista, anche se anch’essi vogliono la sofferenza totale del diverso e la sua eliminazione o asservimento totale. Costoro accompagnano l’odio e i desiderio di distruggere l’altro con bisogni orrendi, paranoici ma anche “umani”, la propria paura, il desiderio di vendetta, il sentirsi migliori, l’andare nel paradiso di Allah con le belle vergini o proteggere i propri privilegi. Il mafioso no. Egli è una figura più robotica, più monolitica e totalitaria. Per questo Falcone diceva: “quando avremo ridotto Cosa nostra ad una semplice organizzazione criminale avremo vinto”. Solo oggi, qua e là, sembrano aprirsi delle crepe con il 41bis, la sottrazione di minori a famiglie di ‘Ndrangheta, qualche amante. Una direzione “camorristica” ancora iniziale sembra comparire qua e là. Citiamo Palermo che oggi, oltre che capitale della mafia è anche capitale dell’antimafia e della cultura. Ci raccontano che nella Valle del Belice siano autorizzate le amanti. Sono casi raccontati dalla collega Zizzo (in Craparo et all., op.cit.). è però un caso che sembra quasi isolato. Su tutti i giornali è invece presente una donna boss, capo mandamento, che è stata a lungo in carcere. Eclatante anche se, certamente, nona gisce in autonomia ma sentendo il marito carcerato. Questo inizio crisi nel monolite antropo-psichico (in certi posti c’è l’incontro con le culture diverse degli immigrati) non sembra però incidere sulla presenza nel territorio sulle richieste di pizzo, sull’”omicidio” quotidiano dello sviluppo. Anche a livello politico il dramma mafia è stato, a parte alcune realtà storiche, trascurato da vecchi e nuovi e l’attenzione è stata portata su altre brutture, dimenticando che questa è in Italia la peggiore. Rinvio ad altre discipline per gli studi che dicono che non c’è mafia “d.o.c.” senza estorsioni, controllo del territorio, evasione fiscale, rapporti con amministrazioni ed amministratori, reti economiche internazionali, ecc.
- Mafia e psicopatologia. Nel testo omonimo appena uscito abbiamo approfondito la questione “la mafia è psicopatologia?”. In genere si risponde di sì ma, in senso stretto, la risposta è no. Il mafioso, infatti, uccide con indifferenza e non ha una struttura di personalità capace di vivere un pensiero soggettivo. Ai nostri occhi questa è una malattia. Agli occhi di tutte le culture tradizionali ognuno era quello che cultura e famiglia gli avevano trasmesso. Si cresceva come il nonno/a. La vita era sul solco di quella dei genitori la famiglia era il centro di tutto e senza di essa non si sopravviveva. Sulle tombe degli uomini era scritto “padre di famiglia ed onesto lavoratore” ( e cioè, la persona coincide con il suo ruolo familiare e sociale); le donne erano essenzialmente madri e mogli. Salvo eccezioni la sessualità consisteva in uno sfogo maschile rapido e in una insensibilità femminile (addirittura la masturbazione era un grave peccato e colpa). L’infibulazione era psicologica e portava ad una non eccitabilità delle donne, accentuata anche dalla cultura religiosa e la velocità dei rapporti, dall’apprendimento “sessuale”(?) dei maschi nelle case chiuse. Queste erano ( e forse ancora in parte sono) i mafiosi. Tutto ciò era finalizzato a costruire dei perfetti killer della mafia, non era una cosa morale. Definendo psicopatologica la mafia cadremmo quindi nell’errore e nella banalità clinico-scientifica tanto studiata dall’etno-psicoanalisi di definire psicopatologia ciò con cui non siamo d’accordo culturalmente o che non reggiamo psichicamente (ad esempio, in passato, l’omosessualità). Il mafioso, però, finchè è pienamente inserito nel monolite totalitario “Cosa nostra” non ha problemi psichici, né angosce, né sensi di colpa. Ha una struttura psichica paranoidea ( a morti è sempri rarreri a porta) che però condivide con tutti gli altri mafiosi e in quel mondo è, quindi, “normale”. Questo modello, perfetto per l’organizzazione, è però fragile. Un mafioso in crisi, collaborante, emarginato va in mille pezzi. Abbiamo visto gente che non dorme, piena di ansia, odio, terrore. In una grande crisi di identità. Sono persone non addestrare ad essere un io, ad avere desideri, conflitti interni, paure colpe. Abbiamo quindi ritenuto più scientifico uscire da schemi socio-criminologici-psichiatrici tradizionali ed inserire la mafia nella categoria della socio-patia. Da un punto di vista del loro rapporto con il mondo la definizione è calzante. Del resto la nostra ricerca-intervento è stata, in questo campo, la prima di carattere sistematicamente psicologico-clinico che si basasse non su speculazioni teoretico-sociali ma su un’enorme raccolta di dati di prima mano fatta con collaboranti di giustizia, magistrati, membri delle forze dell’ordine amministratori, psicoterapeuti, tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione. Gruppi di elaborazione con cittadini di numerosi comuni, interviste in carcere, confronti con colleghi di altre discipline (sociologiche, giuridiche, giornalisti specializzati, ecc.), con associazioni antiracket, con analisi di intercettazioni, in particolare con il fenomeno dei colletti bianchi (Giunta, Mannino, Lo Verso 2017).
- Mafia in psicoterapia
Nel testo viene approfondito il tema a partire da un vuoto. I mafiosi vanno in psicoterapia solo nelle fiction americane. Una identità noi non può essere oggetto di riflessione ed elaborazione. Inoltre, verrebbe gravemente violata la legge dell’omertà (ancora oggi un mafioso ha rischiato di essere ucciso poiché ha patteggiato la pena. Ha, cioè, omesso di avere delle colpe e che le avesse la sua organizzazione). In sostanza, non ci sono casi reali di mafiosi in analisi, anche se i giornali usano sempre questo titolo parlando del nostro lavoro. Noi abbiamo lavorato con collaboranti di giustizia, parenti o persone vicine a vittime di mafia, persone non mafiose ma che erano psicologicamente collegate, ecc. Ho coniato una sorta di equazione! Più sei dentro la mafia ( o ad un fondamentalismo) meno è possibile fare un lavoro di terapia analitica ( e cioè sistematica ed elaborativa) poiché è impossibile pensare ad un sé che non c’è. Se è presente un noi totale una terapia psichica approfondita non può essere fatta. La psicoterapia, inoltre, porta avanti la parola, il pensiero, la ricerca delle “verità” (Bion). Esattamente l’opposto dell’omertosa cultura mafiosa. Chi invece ha grande necessità ( e diritto) di un competente aiuto psicoterapico sono le persone vittime di mafia o a loro vicine. Figli, mogli, nipoti, parenti ed amici in senso lato. Ma anche persone che hanno vissuto nella paura continua per le imposizioni, il pizzo, ecc. in un lavoro fatto con i commercianti aderenti ad Addio Pizzo venne fuori un dato incredibile. La parte dei commercianti che avevano ricevuto minacce e richieste di pizzo aveva gli stessi vissuti della parte che non li aveva ricevuti ma che pensava a questo in continuazione. In sostanza, la fantasia persecutoria di essere aggrediti funzionava psichicamente quanto l’essere realmente in una realtà antropologica come quella siciliana. Fare lavoro psicoterapico”verace” in questo mondo richiede, quindi, un’approfondita formazione su sé stessi che possa aiutare a reggere un contesto così psichicamente violento e chiuso. Un’approfondita conoscenza degli aspetti antropopsichici che sono dentro a chi ha a che fare con la mafia. Un riconoscimento alla correttezza clinico-scientifica del nostro lavoro ci è venuta da collaboranti di giustizia. Mi è stata chiesta un’analisi da carcerati collaboranti con la motivazione “ sa professore, ai suoi colleghi (in genere al Nord) la mafia gli sembra come quella dei film americani”. Noi nei nostri testi abbiamo cercato di rappresentare un mondo reale e terribile.
Riferimenti
Giunta S., Mannino G., Lo Verso G., La dignità tradita: una ricerca psico-sociale sui crimini dei colletti bianchi, Angeli, Mi 2017
Lo Verso G., La psicologia mafiosa: un fondamentalismo nostrano, Di Girolamo, Tp 2017
Craparo G., Ferraro A. M., Lo Verso G. (a cura di), Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di straordinaria follia, Angeli, Mi 2017