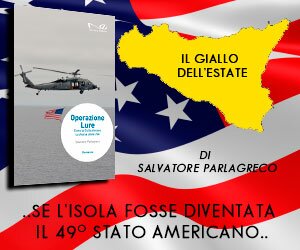Le contraddizioni strutturali che sempre hanno caratterizzato la città di Palermo mai come quest’anno, in cui si celebra la vittoria di un riconoscimento importante, quello di Capitale della Cultura 2018, sono state così forti ed evidenti.
Ogni giorno, tutti i giorni, muore una persona per strada: di freddo, di fame, di abbandono, di solitudine, di emarginazione, in poche parole di povertà estrema lasciando in ognuno di noi un grande senso di rabbia e impotenza che non riesce a trovare alcuna espressione nella politica della nostra amministrazione comunale. Per questa ragione, ci vergogniamo quasi di appartenere a una città Capitale della Cultura: capitale di “quale” cultura? E la domanda non contiene solo un valore semantico, di cui potremmo fare a meno.
Se Palermo presenta tre condizioni particolari la cui coesistenza la distingue da altre metropoli e cioè una rilevantissima domanda debole marginale; una consistente area di famiglie povere a forte rischio; una vasta area di degrado sia edilizio che sociale, distinta tra un grande quartiere centrale e numerose “isole” di povertà e degrado urbano nelle periferie, come mostrano peraltro numerose esperienze europee, questi, è vero, non sono problemi specifici della nostra città. Purtroppo l’arretratezza relativa dell’economia e delle garanzie collettive nel nostro mezzogiorno e la lacerazione nei sistemi di welfare e di protezione sociale nei paesi del Nord Europa mostrano molti punti in comune. Nei “comuni destini” delle città europee c’è oggi il rischio di un generalizzato impoverimento; la diffusione di un nuovo “disagio urbano”; e l’emergere di luoghi specifici di concentrazione della povertà urbana. Forse più intenso, forse più radicato e recidivo, il disagio urbano di Palermo (e delle altre città del meridione), pur non essendo strutturalmente diverso da quello delle altre città europee.
Indubbiamente però su queste tre problematiche, impoverimento, disagio, concentrazione, Palermo ha molto da insegnare, dal lato delle fenomenologie, e molto da imparare dal lato delle politiche, dalle altre esperienze europee.
Già solo in termini di povertà economica, una parte consistente delle famiglie palermitane appare a rischio, sia che il capofamiglia risulti occupato stabilmente o in condizioni lavorative marginali.
Ma il problema è più ampio: perdita di relazioni o “disaffiliazione“, generata da processi di precarizzazione delle condizioni lavorative e da processi di fragilizzazione dei legami sociali che fanno di Palermo una delle capitali italiane per entità di domanda economicamente o socialmente debole, per esempio, gli anziani poveri, o per esempio, per la cosiddetta domanda “anomala” espressa da soggetti particolari privi di tutela, sovrapposta ma non sempre direttamente assimilabile a quella originata da povertà (gli immigrati, i nomadi, gli occupanti di alloggi abusivi).
Comunque definita, Palermo presenta la più alta incidenza percentuale di domanda debole e marginale tra tutte le aree metropolitane; anche in valore assoluto, si situa appena dopo metropoli molto più vaste come Roma, Milano, Torino e Napoli.
Il “disagio urbano” nasce dalla mancanza di una dignitosa condizione urbana, un bisogno non meno cruciale della casa, della salute, del lavoro. In un certo senso, è una dimensione abortita del sistema di protezione sociale, riflette una lacuna nell’idea di cittadinanza sociale. Diffuso in vaste aree delle città, il disagio dipende, senza coincidervi, con i problemi urbani standard (mancanza di abitazioni, carenze infrastrutturali, scarsa qualità). Ma l’attuale disagio, a differenza del disagio tradizionale, non deriva dal divario di numero o di prezzo tra case e famiglie (per il quale basterebbe colmare la differenza per risolvere il bisogno). E’ dove i problemi abitativi si legano con quelli sociali e dove l’esclusione abitativa si lega ad altre forme di esclusione, che si manifesta un nuovo disagio. La disponibilità di un alloggio è spesso il crinale tra appartenenza ed esclusione. E questo è l’aspetto “politico” (nel senso pieno della civis) che è stato trascurato nelle politiche urbane e di cui sono esempi critici i quartieri periferici: chi controlla l’accesso alla casa regola un meccanismo delicato di sicurezza individuale e coesione sociale tanto è vero che gli interessi speculativi si intrecciano spesso con la criminalità organizzata e si avvantaggiano della precarietà di intere comunità. La somma di distorsioni e illegalità nel mercato abitativo ha condotto a un accumulo impressionante di fenomeni di degrado, di abbandono, di cui l’edilizia o le occupazioni “abusive” sono un aspetto. Quando questi lasciti si intrecciano con situazioni di forte povertà e marginalità si creano dunque situazioni esplosive, o semplicemente territori “fuori controllo”. La concentrazione del disagio è il tema più dolente, per Palermo, più sensibile di qualunque altra esperienza europea.
Si sostiene che nel Centro storico si concentrino le situazioni di estremo disagio sociale e di degrado urbanistico. Ma oltre al centro storico vanno considerati anche i borghi storici, che mostrano forse situazioni meno clamorose ma certo non meno difficili per chi vi abita. Forse i caratteri specifici della nostra città sono proprio queste varianti di quelle che in Europa sono chiamate -un po’ genericamente- le aree urbane “in crisi”.
Palermo potrebbe diventare il banco di prova di un modello diverso di politiche urbane: non solo più stringenti, non solo più efficaci, ma orientate ad integrare nell’azione di riqualificazione urbana il complesso delle finalità sociali ed economiche, civiche e urbanistiche. Infatti, non sarebbe bene illudersi che l’avvio del processo di riqualificazione contenga da solo le risposte ai problemi storici della città; in realtà, pone numerose nuove sfide. Per esempio, oltre il 70% degli immobili del centro storico richiederebbero interventi di ristrutturazione e/o sostituzione. Se i pur auspicabili processi di recupero si avviassero senza un approccio integrato in senso proprio, la situazione della popolazione più povera potrebbe addirittura peggiorare.
Forse è possibile che a partire dal lavoro di Palermo si apra una riflessione più ampia che sarebbe di particolare emergenza ora che le politiche abitative nazionali sembrano dichiaratamente inadeguate e in cerca di riformulazione: è probabilmente necessaria una fase di sperimentazione che, come nel secondo dopoguerra, chiami le amministrazioni locali a un ruolo innovativo e di anticipazione sul quadro nazionale, culturale in senso sociale prima che artistico.
Vogliamo qui ricordare che il bando pubblicato dal ministero delle Politiche sociali, che stanzia 2,8 milioni di euro per l’area metropolitana di Palermo nell’ambito delle attività di contrasto alla povertà estrema e marginalità adulta, azione che dovrebbe essere attivata nell’ambito dell’Avviso 4 del Fead, prevede comunità e piccoli spazi di accoglienza, centri diurni e soprattutto una rete di servizi che possa attivare percorsi di inserimento sociale e lavorativo dei senza fissa dimora. Misure che sono state decise dal Tavolo povertà. L’Avviso 4 scade il 15 febbraio; entro tale data quindi il Comune dovrà presentare la propria proposta di finanziamento che riguarderà i servizi da attuare in città per i senzatetto, e vogliamo augurarci che non manchi di sollecitazioni a farlo, visto che la situazione sta precipitando: la povertà non è dovuta ad una calamità naturale, ma alla iniqua distribuzione della ricchezza pubblica e se la forbice tra ricchi e poveri si allarga sempre di più nel mondo intero e nella nostra città, ecco perché noi cittadini ci chiediamo se il modello politico ed economico di chi ci governa non stia per caso all’origine di questa ingiustizia: come è possibile che in una città con un livello di impoverimento così alto da paragonarci alla crisi del dopo guerra non si riescono a spendere le risorse economiche destinate ai senza casa? Come è possibile che il vastissimo patrimonio immobiliare pubblico del Comune e delle Istituzioni Statali, Regionali non viene utilizzato, dai politici da noi eletti? Perché non è possibile sapere dai bilanci consuntivi cosa è stato speso e soprattutto come, delle risorse pubbliche, frutto delle nostre tasse? Nel sito del Comune sono state pubblicate soltanto le somme complessive delle entrate e delle uscite senza specificare i capitoli di spesa da cui si evince ciò che è stato realmente speso nello specifico capitolo e come è stato speso: non abbiamo forse il diritto di sapere dall’Amministrazione come ha custodito le risorse della città e come ha speso i nostri soldi?
Se Palermo è stata riconosciuta Capitale della Cultura 2018, come si legge nel lungo dossier relativo appunto al riconoscimento, è stato grazie alla capacità di “accoglienza” che la città ha dimostrato; nella “Carta di Palermo”, il documento di sostegno, si afferma la necessità di evitare la cronicizzazione delle emergenze, tutte per altro riconducibili ad un dato strutturale, ovvero l’impossibilità di bloccare lo spostamento di milioni e milioni di esseri umani. “In tale prospettiva”, si legge, “la soluzione alle emergenze presenti in tutto il mondo e non soltanto nel Mediterraneo, non può prescindere da una visione progettuale che abbia come elemento centrale il riconoscimento del migrante come persona, e dunque la promozione della mobilità di tutti e di ciascuno come un diritto umano inalienabile. Ogni altro aspetto, ivi compreso il concetto di sicurezza, troppe volte e impropriamente invocata, deve essere dunque trattato coerentemente a tale impostazione”.
Come può accadere, dunque, che immigrati e cittadini muoiano ancora agli angoli delle strade in tutta la città? Come possiamo, in questo inverno per molti infelice e foriero di morte, apprezzare che la nostra città sia stata riconosciuta “Capitale della Cultura”?
Cultura non è “Manifesta”, quell’importante Biennale d’Arte Contemporanea che la città si vanta di ospitare, godimento di pochi eletti: Cultura è strumento di confronto, di conoscenza dell’altro, di superamento delle differenze come ostacolo alla convivenza pacifica; Cultura è il luogo della elaborazione di dispositivi concettuali e semantici che trovano nel tema dei diritti il laboratorio politico e culturale della nostra città. La Cultura genera consapevolezza di sé e del proprio ruolo sociale e impone categoricamente il riconoscimento dei diritti individuali e collettivi: il diritto dell’altro è e deve essere assunzione consapevole, in primis, dei propri doveri.